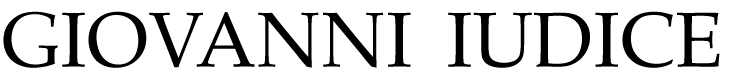Per Giovanni Iudice
La luce bonnardiana della Stanza, 2000, ripensata sulla tradizione nuova dei Freud e dei Pearlstein. Così, in sintesi, e a voler essere generici, si potrebbe racchiudere in slogan l’approccio pittorico di Giovanni ludice. Ma si sarebbe, appunto, generici, e ingenerosi. Iudice non muove da modelli rassicuranti scegliendosene epigono. Una tradizione riconosce, ma con amore feroce e lucido, senza rispetto. Questo dicono, primariamente, le misure fiamminghe delle tele e delle tavole, sulle quali egli interviene con lavorio cautelato, assorto, in cui lo scrutinio di ogni passaggio comporta l’addensarsi lento e meticoloso dei toni, dei veli, come per coagulo luminoso. Circoscritto, padroneggiabile è l’ambito della definizione pittorica, ossessione sottile della finestra e, più, spazio rappreso in cui l’arroganza della visività può ribaltarsi, per accelerazioni e deviazioni
infinitesime, in passo visionario.
Alla visione, al regard, egli si rivolge elidendo ogni affettazione di stile e di modo, con sguardo diretto e arguto, con l’umiltà, in prima istanza, di un what you see complice della storia dei rapporti tra pittura e fotografia, senza l’abbigliamento di una preventiva clausola di sottrazione e di trascrizione. Altro gli sta a cuore. Il farsi forma e, più, il farsi clima emotivo della scena attraverso la luce; della luce, quell’incidere sui corpi, quel bagnarli delle proprie temperature restituendoli in sorta di apparizioni di dubitante fisicità, di sfuggente plasticità, di inafferrabile sensualità, ma di intensa presenza; della presenza, quella reticenza narrativa, quella istantaneità atmosferica, come momento non esemplare di una fluenza luminosa che vale il tempo.
Ecco, dunque, l’operare sui toni in diminuendo, come scavando nell’ombra, negli interni, che rimontano alle bianchezze di luce diurna senza algori mentali, come per transito naturale d’affetti.
Ecco, per converso, i paesaggi marini e, più, la scommessa tematica di Nudo nell’orto, tentare condizioni luminose alte, piene, quasi un nitore che la luce solare rende esemplare, fra dorature meridiane e toni argentini. ludice va saggiando, in questo suo ancor breve corso d’opera – ma che ne fa, già, una delle figure problematicamente più autentiche e interessanti della generazione nuova, una sorta di metabolizzazione definitiva dello iato tra modernità a tradizione, tra vero ottocentesco e artificio mentalmente analizzato novecentesco, in nome di una normalità dello sguardo che sia consapevole, colta, orgogliosa dei propri retaggi storici, ma a un tempo capace di esercitarsi per visioni fragranti, dirette, non allusive ad altro che alla propria qualità d’esperienza.
Non è un caso, in tal senso, che egli operi attentamente, parimenti che alla identificazione del tono luminoso, sul taglio d’immagine, bordeggiando i protocolli di genere ma sempre immettendovi deviazioni significative: non è, il suo, un comporre ordinato, ma un continuo decostruire e ricostruire, sino al punto in cui la visione si innesca di una sorta di teso equilibrio interno, appena riverberante ma fondamentale per far lievitare la più esplicita azione sui valori di tono.
Molto di tali ambizioni pittoriche è nei quadri presenti, e molto altro si intuisce, in termini di sviluppi, precisazioni, decantazioni. E un lavoro con un destino, quello di ludice: del quale, è certo, sarà assai fruttuoso esser curiosi.
In catalogo “Giovanni Iudice”, 2002
Galleria Brera 5 Milano edizioni Mazzotta